Ai piedi della croce
Rossana aveva 23 anni quando le venne diagnosticato un tumore cerebrale. Era una bellissima ragazza, forte e volitiva. In quel giorno di aprile in cui la diagnosi venne ufficializzata, il mondo per lei e per i suoi genitori, che avevano quell’unica figlia, si fermò. I medici dissero fin da subito che per quella forma particolare di cancro non esisteva una cura risolutiva, ma che avrebbero tentato ogni terapia pur di allungare i tempi di sopravvivenza (mediamente di un anno e mezzo, due) nella speranza che la ricerca, nel frattempo, trovasse ulteriori cure. Rossana di anni ne visse tre, tra interventi e terapie. Pochi mesi prima di andarsene riuscì anche a discutere la sua tesi di laurea magistrale. Alla fine salutò i suoi genitori in una caldissima giornata di agosto, a 26 anni. E quel sole bellissimo che splendeva nel cielo, diventò d’un tratto emblema dell’ingiustizia più atroce, quella di un padre e di una madre che sopravvivono alla propria figlia.
Davide di anni ne aveva invece 19. C’era una nebbia fitta la sera in cui l’automobile nella quale si trovava prese il cordolo di una rotonda e si ribaltò schiacciando la sua vita e quella del ragazzo che era con lui. E sua madre Eugenia (entrambi i nomi sono di fantasia) da allora non si è più ripresa. Anche se sono passati tredici anni, il dolore che le è calato nel cuore non solo non l’ha più abbandonata, ma le ha impedito di immaginare ogni futuro possibile. Sopravvive un giorno alla volta, «aspettando solo il momento in cui lo rivedrò» confida. Per lei tutto è successo troppo in fretta, non ha avuto nemmeno il tempo di dire addio a suo figlio. E quel saluto mancato le brucia dentro come un ferro incandescente che le scava la carne orfana della sua creatura.
Il dono di Rossana
«Poche settimane dopo che Rossana ci aveva lasciato, cominciai a pensare che lei non avrebbe mai voluto vedermi così frastornata, senza obiettivi e senza meta, alle prese con un dolore profondo, disumano, inspiegabile e soprattutto innaturale, al punto tale che per descriverlo non esiste nemmeno una parola – racconta oggi Maria Teresa, la mamma di Rossana, che sulla sua esperienza ha scritto tre libri, Il dono di Rossana, Come fiori liberi e L’alba che ci aspetta (acquistabili sulle principali librerie online) –. Piano piano iniziò così a maturare dentro di me l’idea che avremmo dovuto e potuto, io e mio marito Mario, fare qualcosa per dare un senso alla partenza di nostra figlia. Ne abbiamo parlato a lungo, ci siamo confrontati e poi ci siamo ricordati che un giorno Rossana ci aveva confidato che le sarebbe piaciuto, se fosse guarita, raccogliere fondi per la ricerca scientifica. Avrebbe voluto addirittura dedicare il suo tempo e le sue energie a sostenere direttamente chi si fosse trovato nelle sue stesse condizioni. E così abbiamo raccolto la sua eredità, costituendo un’associazione che potesse in qualche modo proseguire la vita di nostra figlia, interrottasi troppo presto. Il 10 ottobre 2018, ad appena due mesi dalla morte di Rossana, abbiamo pertanto costituito l’associazione “Il dono di Rossana” che, attraverso varie attività di sensibilizzazione, anche nelle scuole, raccoglie fondi per sostenere progetti di ricerca, borse di studio, tesi di laurea che studiano i tumori cerebrali, sperando che si riesca a trovare presto una terapia innovativa. Il dolore per la morte di Rossana è sempre con noi, è sempre con me. L’ho accettato e so che sarà, fino alla fine, il compagno dei miei giorni. Ma, insieme a lui, accanto a me c’è Rossana, c’è la sua presenza che non mi abbandona, ci sono i nostri ricordi, c’è uno stare insieme che ora vive in un’altra dimensione, in un Oltre a cui non so dare un nome, ma che so esiste. E l’associazione mi ha aiutato a dire a me stessa e al mondo che la morte non ha l’ultima parola, che dalla morte può nascere vita, tanta e buona. Rossana è stata un dono per noi, certo, ma lo è ancora oggi anche per quanti, grazie a lei, possono avere una speranza in più di poter guarire».
Perché alcuni sì e altri no
La vicenda di Eugenia, la mamma di Davide è differente rispetto a quella dei genitori di Rossana. A lei il dolore non ha lasciato scampo. Succede anche questo, e non siamo autorizzati a esprimere alcun giudizio. Solo a cercare di capire, forse, come mai alcuni riescono a ripartire e altri no. Ne scrive ampiamente Massimo Recalcati nel suo bellissimo libro La luce delle stelle morte. Saggio su lutto e nostalgia. La morte di una persona cara, sostiene lo psicanalista, apre sempre spazi di nostalgia, una nostalgia che però può essere di due tipi: quella che si focalizza unicamente sul passato, sullo struggimento per la mancanza di una persona che non è più con noi, una mancanza che ferisce dunque continuamente la nostra vita come in un eterno presente, e quella che, pur riconoscendo la mancanza atroce di chi abbiamo perduto, ci aiuta a intravederne la luce buona che ancora oggi ci illumina, proprio come la luce delle stelle che noi oggi osserviamo e che ci raggiunge a distanza di milioni di anni dalla loro morte. Sarebbero quindi i ricordi buoni che abitano la mente a illuminare la vita, rendendo possibile un futuro anche dopo aver perduto un figlio. In altre parole, più semplicistiche forse, a fare la differenza parrebbe essere la capacità di uno sguardo grato su ciò che è stato, sul dono della vita condivisa con la persona che non c’è più, piuttosto che la «fissazione» (psicologicamente intesa) sulla sua mancanza.
Detto così sembra quasi facile, ma, in realtà, non lo è per nulla. C’è un cammino difficilissimo da compiere per riuscire ad affrontare il lutto in chiave generativa, vale a dire in un modo che alla morte risponda con la vita. Perché «i genitori a cui muore un figlio – spiega Paola Argentino, psichiatra e psicoterapeuta, co-direttrice del master universitario in psico-oncologia dell’Università cattolica del Sacro Cuore e autrice del recente saggio La spiritualità è cura: la forza dell’amore nel dolore – sono all’inizio come risucchiati in una voragine di dolore senza fondo, e accade una destrutturazione della loro identità personale e sociale. Vivono una deflagrazione affettiva che lascia ferite molteplici e profonde non solo nel cuore, ma in tutto il loro corpo. Si tratta di ferite impossibili da cicatrizzare in modo stabile, in quanto tendono a riaprirsi e a sanguinare costantemente, a ogni evento della loro vita, perché tutto, proprio tutto, richiama direttamente o indirettamente l’assenza del figlio».
A rendere ancora più doloroso il lutto e complessa la sua gestione ci sono anche le «modalità» della perdita. «Le situazioni sono molto diverse – conferma Paola Argentino –. Se, per esempio, la morte è sopraggiunta dopo una malattia grave cronica, progressiva, degenerativa, con necessità di cure estenuanti, il dolore certo non è minore, ma i familiari hanno avuto il tempo di prepararsi all’evento di separazione definitiva e, sebbene non si sia mai pronti psicologicamente alla morte, in questi casi il percorso di elaborazione del lutto è, per così dire, “facilitato” nel raggiungimento di una pace interiore. Se invece la morte è avvenuta all’improvviso, in piena salute, per un evento traumatico esterno al soggetto (incidenti stradali, catastrofi naturali, omicidi, ecc.), essendo stato brevissimo o nullo il tempo di preparazione al distacco, ci sarà bisogno di un tempo di elaborazione del lutto molto più prolungato. Ancora più complesso e protratto sarà il tempo di ripresa dopo una morte per autolesione (suicidi consapevoli o indotti per plagio o giochi pericolosi), perché non è possibile attribuire a un evento esterno la causa della separazione affettiva, eccetto che alla volontà del soggetto, che sembra aver escluso la possibilità di affidarsi a una richiesta di aiuto in vita ai genitori. E quest’ultima consapevolezza è l’ostacolo maggiore per l’elaborazione del lutto».
In tutti i casi, il percorso che attende quelle madri e quei padri resi «orfani» della carne della loro carne è difficile, doloroso e molto lungo. E, soprattutto, richiede, oltre che la messa in gioco di risorse psichiche e psicologiche, l’affidarsi a una “corporeità”, che può aiutare a concretizzare, a mostrare e quindi ad accettare il dolore. «Freud – sottolinea a riguardo la professoressa Paola Argentino – afferma che il lutto è una delle esperienze più traumatiche della vita umana e per essere superata richiede un vero e proprio “lavoro mentale”. Pur concordando con il padre della psicoanalisi sulla traumaticità del lutto, io credo che non si tratti esclusivamente di un lavoro mentale, ma di una esperienza di separazione intercorporea che si esprime nel corpo, in modo più frequente, con la produzione di lacrime, da dove si origina il termine “lutto”, dal latino lugere, che significa “piangere”. Lo scrive bene il monaco Simeone nei suoi Inni: “La sofferenza trasforma l’anima in una fonte di lacrime”, ma le lacrime sono un dono di inestimabile valore perché in grado di esprimere emozioni profonde e devastanti, anche quando il dolore ha consunto tutte le parole. Esse creano un linguaggio nuovo, una comunicazione alternativa alle parole, che, pur nel silenzio, è densa di suoni arcaici: la voce dell’anima. Non a caso la poetessa Alda Merini canta: “E beati voi / che avete il dono delle sante lacrime, / e se anche le trovate ingiuste / agli occhi di Dio appariranno rugiada / che farà crescere rose nella vostra carne”».
Il lutto per la perdita di un figlio coinvolge quindi un genitore in ogni componente della vita, corpo, mente e anima. Per questo ci sono esperienze che, dando libero sfogo alla voce di questo dolore totalizzante, possono rappresentare l’inizio di un cammino di rinascita. «L’aspetto a mio avviso tra i più importanti come fonte di grande aiuto e conforto per l’elaborazione del lutto – conclude Paola Argentino – è la solidarietà che si sperimenta nella condivisione di gruppo. E ciò vale soprattutto nei casi di lutti gravi, improvvisi, dove neanche il tempo della malattia ha potuto preparare e attutire il dolore per la perdita del proprio figlio. Penso ai gruppi di Auto Mutuo Aiuto nel lutto (i cosiddetti gruppi AMA) che hanno avuto un impatto sociale positivo e di sostegno nell’ultimo periodo storico, specialmente per i lutti durante la pandemia. Quando il “non detto” riesce a emergere dalle cicatrici del cuore nel pianto liberatore, le lacrime diventano strumento di condivisione e richiamo intimo alla relazione affettiva. Attraversando la propria sofferenza, vivendola fino in fondo con tutte le proprie lacrime, si opera la trasformazione dal dolore in quanto lacerazione al dolore in quanto cordoglio condiviso (da qui il termine “condoglianze”) che porta alla re-integrazione della persona, alla riunificazione delle parti disgregate del suo Sé intercorporeo, cioè di un corpo in relazione con altri corpi. È un processo generativo che consente di affrontare positivamente il vissuto di dolore e di trasformare la propria sofferenza anche in un prezioso impegno di vita per l’umanità».
Il gruppo Nain
Sorta nel 1991, per opera di don Luigi Verdi, attorno a una suggestiva Pieve romanica, la Fraternità di Romena si trova in un luogo incantevole del Casentino. Uno di quei posti del cuore dove il bello si cela ovunque. Punto di incontro per viandanti alla ricerca, contesto di accoglienza che sa superare differenze, credo e provenienze per favorire relazioni autentiche, Romena è anche il luogo in cui ogni ultima domenica del mese fa tappa il gruppo Nain. «Nain era il nome della cittadina in cui, secondo il vangelo di Luca, Gesù risuscitò il figlio di una povera vedova. È un nome, dunque, che evoca la speranza, la certezza che la morte non ha l’ultima parola – racconta don Luigi Verdi –. Per questo Nain è anche il nome che abbiamo scelto per il gruppo di genitori che hanno perso un figlio, che da anni qui si riunisce». L’intuizione del gruppo venne anni fa proprio a don Luigi. «Mi capitò di sentire un prete – confida don Luigi – dire a un genitore a cui era morto un figlio: “Tuo figlio era più buono di un altro, Dio l’ha voluto in paradiso con sé”. E io pensai: “Basta, non possiamo più dire queste cose, non possiamo offendere in questo modo il dolore delle persone”. Il dolore è sacro. Per cui mi è venuto il desiderio di stare vicino a questi genitori feriti in un altro modo, per cercare di dare un senso alle loro perdite, per non buttare là risposte banali. Di lì a poco, e senza che io facessi nulla, arrivò la prima coppia di genitori, poi ne giunse un’altra e così via. Oggi sono una catena infinita: solo nell’ultima settimana ne sono arrivati tre a cercare consolazione».
Le madri e i padri giungono da tutta Italia e si uniscono al nucleo storico del gruppo formato da un centinaio di persone, «perché è una modalità che funziona – spiega don Luigi –. Io ai preti lo dico sempre: create gruppi di genitori che hanno perso un figlio, non lasciateli soli, perché alla fine ogni parrocchia di queste situazioni ne ha almeno una decina...». Il gruppo Nain ha una caratteristica particolare, come spiega ancora il suo fondatore: «In giro vedevo tanti gruppi di elaborazione del lutto che a mio avviso erano o troppo “psicologici” (e non va bene, perché alla fin fine non si può stare troppo a rigirarsi nel dolore) oppure troppo spiritualisti (preghiere, Messe, preghiere, Messe: importanti, certo, ma che non coglievano l’aspetto più umano del dolore di questi genitori). A me sembrava che nessuna di queste due modalità alla fin fine aiutasse molto le persone. E così ho provato una strada diversa: semplicemente prendo le domande crude dei genitori (“Perché a me?”, “Dov’eri Dio quel giorno che è morto mio figlio?”, “Da dove ricomincio ora che non ho più mio figlio?”) e cerco di abitarle. Noi troppo spesso siamo fermi a modalità da vecchio catechismo, per cui a ogni domanda ci deve essere sempre una risposta. Ma non è così, non sempre si può dare risposta. Io a questi genitori semplicemente dico: “Non lo so perché ti è morto il figlio, non so nemmeno che cosa si può fare. Ma restiamo insieme, piangiamo insieme, camminiamo insieme, speriamo insieme, troviamo insieme una soluzione. Alla fine, il mio è solo uno stare accanto che rimanda a quell’immagine che, secondo me, è la più bella del brano evangelico in cui si narra l’episodio di Nain: Gesù non apre bocca, semplicemente va lì e tocca la bara del bambino morto. Perché dinanzi al dolore servono più gesti che parole».
«Una delle domande più difficili che un genitore che ha perso un figlio si pone – insiste il sacerdote – è: “Ma se Dio è onnipotente, perché non ha salvato mio figlio?”. Anche in questo caso io non ho risposte. Quello che posso dire, perché l’ho scoperto insieme a quei padri e a quelle madri, è che il dolore fa parte della vita. Dio ci ha lasciati liberi, ci ha donato la vita perché noi la vivessimo al meglio e dinanzi al mistero del dolore Lui semplicemente ci accompagna, cammina con noi. Dio fa sempre gesti molto umani e noi, quando amiamo, facciamo sempre gesti molto divini. Ricordo una mamma al capezzale del suo bambino che stava morendo di leucemia, all’ospedale Meyer di Firenze: gli stringeva le manine e piangeva. Guardandola, avevo notato che spostava continuamente la testa a destra e a sinistra e io, non capendone il motivo, pensavo fosse come impazzita di dolore. E invece faceva quei movimenti per bere le proprie lacrime, affinché non cadessero sulle manine del figlio e lui non capisse che stava piangendo. Questi sono i miracoli dell’amore, di quell’amore fatto a immagine di Dio. Dio non si può banalizzare. E allora dinanzi al dolore la prima cosa che possiamo fare è appoggiare la testa sulle spalle di Dio e piangere con Lui, mentre Lui piange con noi».
«I genitori che arrivano a Romena – gli fa eco Maria Teresa Abignente, medico che anima insieme con don Luigi il gruppo Nain – hanno bisogno di poter essere se stessi, di piangere, arrabbiarsi, maledire il destino senza sentirsi giudicati da nessuno. Loro sentono che il dolore che provano mette a disagio gli altri e per questo, nella loro vita quotidiana, sono costretti spesso a indossare una maschera. Qui trovano invece uno spazio di verità e autenticità: se vogliono piangere piangono, se vogliono ridere ridono. Questo solo conta e conta per tutti i tipi di dolore. Noi diamo loro solo la nostra vicinanza, che è poi quello che dovrebbe fare chiuque si trovi accanto a un padre o a una madre che abbia perso un figlio, senza cercare nemmeno di azzardare risposte, perché risposte non ci sono. Ciò che fa soffrire questi genitori è l’amore ferito. Ma l’amore non è morto: né il loro né quello del figlio. Bisogna riscoprirlo, riconoscerlo e poi riviverlo. Ed è esattamente quello che proviamo a fare insieme qui a Romena. Il linguaggio che condividiamo con questi genitori non è filosofico e nemmeno teologico, è semplicemente umano, e il suo approdo naturale è la ricerca. I genitori capiscono presto, in genere, che non possono fermarsi e restare nel dolore, ma che, proprio attraverso quel dolore, sono chiamati a modificare qualcosa della propria vita, mettendo in discussione tutta la loro precedente esistenza. E infatti, dopo qualche anno, molti lo ammettono: “Oggi io sono una persona migliore”. Non c’è segno di risurrezione più grande di questo».
Restando in tema di risurrezione, a Romena c’è un grandissimo prato verde, in un dolce pendio, pieno di mandorli, che si chiama proprio Giardino della Risurrezione. È ancora don Luigi a spiegarne la genesi: «Ho sempre cercato nuovi gesti da compiere dinanzi all’inutilità delle parole. E un giorno, riflettendo, mi ritrovai a pensare al mandorlo, il primo albero che fa i fiori e l’ultimo che dà i frutti e che, proprio per questo, assomiglia a quei genitori che sono chiamati a fiorire quando l’inverno non è ancora terminato nel loro cuore e a custodire quei fiori affinché possano portare frutti. Così non solo ho fatto dipingere un grande mandorlo sui muri della sala in cui il gruppo Nain si ritrova, ma ho anche pensato di proporre, a chi lo desiderava, di piantarne uno, sul quale poi appendere la foto del proprio figliolo o un piccolo oggetto che ne fa memoria. Oggi a Romena ce ne sono 300 e molti altri sono stati piantati nei luoghi di provenienza dei genitori. E stanno lì a ricordarci che sono i genitori che oggi devono custodire e portare avanti la vita dei figli che non sono più accanto a loro, nell’attesa di un futuro che sarà portatore di frutti. Purtroppo non tutti riescono a rifiorire, perché si sentono colpevoli di poter tornare a sorridere senza le loro creature. E allora capita anche che qualcuno decida di togliersi la vita. Ricordo una mamma che, proprio mentre cominciava a stare meglio, si gettò sotto un treno, perché non poteva accettare l’idea di poter essere felice senza suo figlio, pensava di non meritarlo. Ma se c’è una cosa di cui io sono certo è che i figli, ogni figlio, anche quelli che se ne sono andati, sono contenti, invece, di vederli felici, pieni di vita e non di morte. Se potessero, alle loro mamme e ai loro papà direbbero: “Voglio che tu non muoia come donna, come uomo, ti voglio vivo. Ti voglio veder fiorire”».
Prova la versione digitale del «Messaggero di sant'Antonio»!









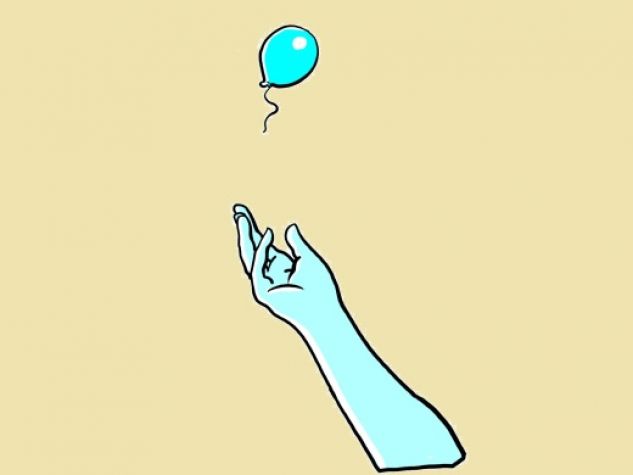

1 comments