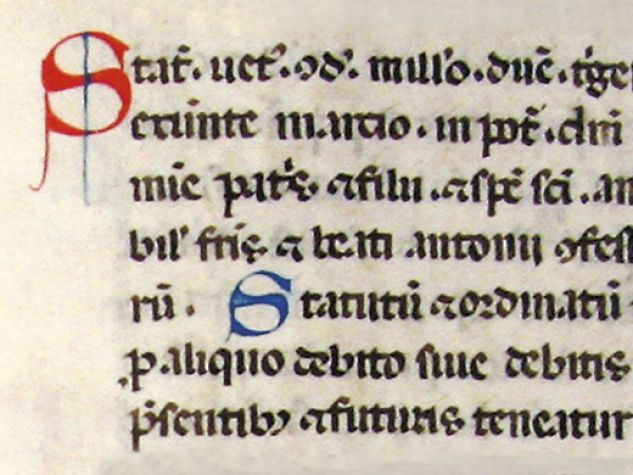Un archeo-regista per Gaza
Gaza, gennaio 2009. Tra le macerie del quartiere periferico di al-Zeitoun una bimba raccoglie da terra un pezzetto di legno e traccia un cerchio dove un tempo affondava le radici uno splendido sicomoro. «Noi bambini ci arrampicavamo per raccogliere i frutti… Era grande. Copriva la metà della strada… – ricorda la piccola Amal abbassando lo sguardo –. Qui prima della guerra era tutto coltivato, c’erano moltissime piante…». La telecamera compie un’ampia panoramica sul nulla. Palazzoni abbandonati, alberi divelti, sterpaglie e cocci seminati qua e là. Di tanto in tanto si sofferma sui dettagli e, guidata dai ricordi della giovane testimone, tenta di ricostruire quel che non c’è più.
Inizia così La strada dei Samouni, il documentario che lo scorso maggio ha conquistato il Festival di Cannes, aggiudicandosi l’Oeil d’or alla Quinzaine des realisateurs. Dietro l’obiettivo Stefano Savona, un palermitano classe ’69 trapiantato a Parigi che, con una laurea in archeologia alla Sapienza di Roma, dal 1999 ha fatto della regia una missione di vita (non a caso tiene corsi alla Fémis di Parigi, al Centro sperimentale di cinematografia di Palermo e all’accademia HEAD di Ginevra). «Già a 5 anni sognavo di diventare archeologo – ricorda oggi al telefono –. A 19 iniziai a frequentare gli scavi in Sudan, Turchia, Egitto. Paesi caldi, flagellati da colpi di stato e lotte civili. Più conoscevo i luoghi e le persone attorno a me, più la passione per l’antico vacillava. Capii di voler raccontare storie vere e attuali ».
Il giovane Stefano s’improvvisa così fotoreporter. Ma la concorrenza è grande e vivere dei pochi scatti pubblicati quasi impossibile. «A partire dal 1997 passai, dunque, alla videocamera. E capii subito che il cinema del reale era la mia strada». Due anni dopo Savona confeziona il suo primo documentario: «Un lungometraggio su una nave curda carica di profughi, che approdava in Italia». Seguono pellicole dedicate ai guerriglieri del PKK (Primavera in Kurdistan, 2006) e alle proteste egiziane contro il regime di Mubarak (Tahrir Liberation Square, 2011). Il regista si sofferma anche sull’occupazione di un palazzo pubblico siciliano da parte di famiglie senzatetto (Palazzo delle Aquile, 2011), non prima di aver affrontato la «questione palestinese».
Faccia a faccia con la tragedia
È il 2009 quando, attraverso l’Egitto, Savona riesce a intrufolarsi a Gaza durante l’operazione «Piombo fuso» dell’esercito israeliano. «Sono ricorso a documenti falsi e mi sono introdotto in cunicoli sotterranei – ricorda –. Un’esperienza pericolosa e dal forte impatto psicologico». Inizialmente l’obiettivo di Savona è documentare la guerra in tempo reale attraverso un video-blog (poi confluito nel film Piombo Fuso). Un giorno, però, Stefano capita insieme a un gruppo di giornalisti nel quartiere di al-Zeitoun, adiacente a un vecchio insediamento ebraico. Là incontra quel che resta dei Samouni, una famiglia di contadini falcidiata dai militari israeliani (ventinove membri uccisi tra padri, madri, sorelle, fratelli e zii).
A differenza dei reporter che restano a documentare lo scempio qualche giorno, il regista rimane con Amal, Fuad, Faraj e gli altri (in gran parte orfani dai 10 ai 20 anni) per un mese. Filmandoli, condivide con loro la quotidianità e si lega di un’amicizia fraterna (non a caso viene soprannominato «il Samouni », come a dire «uno di famiglia»). «Armato» solo di telecamera e microfono, Savona si tiene distante dal patetico compianto della tragedia, come pure dalla denuncia fine a se stessa. Suo obiettivo è ricomporre un’umanità lacerata, ricucire il passato col presente e venire a patti col dolore. Un’operazione lunga e complessa che gli richiederà altri due mesi a Gaza l’anno successivo e, in totale, nove anni di lavoro tra riprese e postproduzione.
«Ci ho messo tanto perché volevo trovare il modo di raccontare i Samouni senza ridurli a semplici vittime. Era fondamentale non lasciarsi tradire dall’emozione, prendere le distanze dai cliché mediatici e ricomporre le ferite». Fisiche ed emozionali. «Un grido senza profondità è inutile » sentenzia il regista. Per questo egli definisce La strada dei Samouni un lavoro di «ricostruzione», un restauro preciso e obiettivo. Da vero archeologo. Per rendere onore ai morti, ma anche ai vivi. E per non arrendersi alla paura. Proprio in tale senso va letta la scelta di alternare alle immagini del girato i disegni in 3D di Simone Massi (sua la tecnica del «graffio su carta», cupa e realistica senza mai sconfinare nel macabro). Tra flashback animati e desolanti panorami reali, i protagonisti della pellicola si trovano di fronte a una scelta: perseguire la vendetta e radicalizzarsi nell’odio oppure recuperare la memoria dei propri cari e guardare al futuro.
Scelgono la seconda via. Rifiutano la tessera di rifugiati Onu, non cedono neppure alle lusinghe degli estremisti che vorrebbero strumentalizzare la loro storia. E tornano alla terra, che rappresenta la loro identità. A un anno dalla tragedia, i Samouni possono già raccogliere i primi frutti della fatica. Stefano Savona è di nuovo lì con loro e documenta stupefatto. «La cosa più importante che quella famiglia mi ha insegnato? L’attaccamento alla realtà e alle cose pratiche. Il saper guardare avanti con speranza e dignità». Una lezione che non s’impara facilmente e che, una volta appresa, ti segna per sempre. Sarà per questo che ancora oggi il regista di La strada dei Samouni non riesce a voltare pagina. Poco importa se il documentario presentato all’ultimo Festival di Cannes ha raccolto ottimi consensi, facendo versare più di qualche lacrima tra il pubblico in sala.
«Mentre giravo a Gaza, la mia più grande paura era quella di non aver messo bene a fuoco, che non si sentisse l’audio – ricorda Savona –. A lungo, anche dopo il mio ritorno a Parigi, sono rimasto ossessionato da ciò che ho visto. Persino ora che ho restituito, finalmente, tutta la storia dei Samouni alla pellicola, la mia liberazione non è totale». Al regista resta infatti da compiere un ultimo sforzo. «Nell’arco di qualche mese spero di tornare a Gaza per mostrare il mio film ai diretti interessati. Solo così, poi, riuscirò a concentrarmi su nuove storie». Storie che, proprio come quella dei Samouni, Stefano Savona porterà sempre nel cuore.